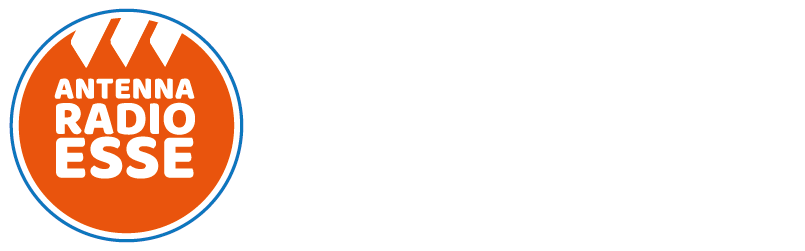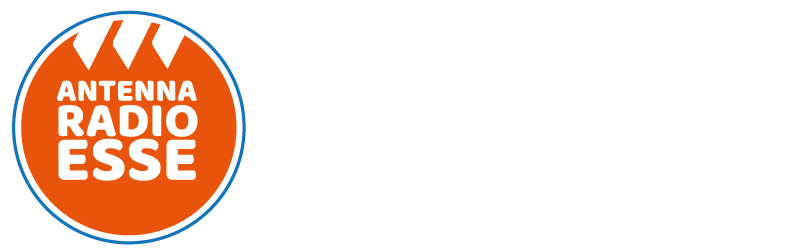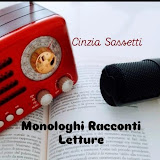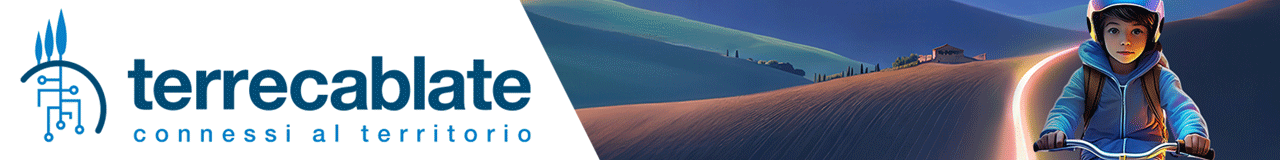Scoperto a Siena il meccanismo che dopo un’influenza o vaccino antinfluenzale fa sviluppare questa malattia in particolari soggetti
Un team internazionale di ricercatori, coordinato dal Centro Ricerche senese di Novartis Vaccines and Diagnostics srl (società del Gruppo GSK), con la collaborazione del professor Franco Laghi Pasini dell’Università di Siena e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, del professor Emanuele Montomoli e della dottoressa Claudia Trombetta dell’Università di Siena, ha scoperto il meccanismo attraverso il quale, in soggetti geneticamente predisposti, dopo un’influenza o una vaccinazione antinfluenzale si può sviluppare la narcolessia. Lo studio è stato pubblicato dalla rivista Science Translational Medicine.
E’ stato dimostrato dai ricercatori come questa malattia sia la conseguenza di una interazione tra infezione da virus influenzale o somministrazione del vaccino e substrato genetico (HLA-DQB1*0602) di determinati soggetti. Dal momento che nello sviluppo della malattia entra in gioco una particolare proteina, la nucleoproteina A, per ridurre il rischio di sviluppare la narcolessia la strada da percorrere è dunque quella della vaccinazione antinfluenzale con vaccini a ridottissimo contenuto di questa nucleoproteina, proteggendo contemporaneamente gli individui dall’infezione influenzale.
Ma come e perché si può sviluppare la narcolessia in determinati soggetti predisposti? Mediante l’utilizzo di sofisticate tecniche molecolari è stato osservato come una piccola porzione di una nucleoproteina del virus dell’influenza A mostri una elevata somiglianza strutturale con una parte del recettore 2 per l’ipocretina, presente in minore concentrazione nei pazienti affetti da narcolessia (il recettore 2 è uno dei recettori a cui si lega normalmente il neuropeptide ipocretina).
In soggetti geneticamente predisposti alla narcolessia ed infettati con il virus selvaggio dell’influenza A, l’organismo produce anticorpi contro la nucleoproteina A virale, che possono legarsi anche al recettore 2 dell’ipocretina.
Quando il recettore è bloccato da questi anticorpi A, il neuropeptide ipocretina non può legarsi: ciò determina un difetto di segnalazione neurorecettoriale specifica che comporta l’insorgenza di narcolessia.
Alcuni, ma non tutti i vaccini anti-influenzali contengono sufficiente quantità di nucleoproteina A, capace di stimolare anticorpi specifici, in grado di interagire, in maniera incrociata con il recettore 2 dell’ipocretina, inducendo un blocco del legame con il neuropeptide.
La composizione dei vaccini influenzali varia da produttore a produttore in rapporto alle differenze di preparazione dei singoli vaccini.
L’infezione con virus influenzale genera titoli anticorpali nei confronti della nucleoproteina molto più alti di quanto avvenga con il vaccino. Pertanto il rischio di sviluppare narcolessia è molto maggiore a seguito di infezione influenzale rispetto a quello conseguente alla vaccinazione, nei soggetti geneticamente suscettibili alla malattia. I dati suggeriscono dunque come i vaccini anti- influenzali debbano essere preparati, al fine di risultare più sicuri anche per i soggetti a rischio genetico di sviluppare narcolessia: 1. diminuendo la quantità di nucleoproteina nel vaccino o 2. rimuovendo la piccolissima parte della nucleproteina A che “mima” la struttura del recettore 2 dell’ipocretina.
Concludono i ricercatori che “testare il fattore genetico di rischio HLA-DQB1*0602 nella popolazione, allo scopo di decidere circa la vaccinazione o meno, non è di uso pratico e neppure utile dal momento che il fattore di rischio non è modificabile”. Il prossimo passo nella ricerca sarà dimostrare come gli anticorpi A, che si riscontrano nel sangue, possano raggiungere il sistema nervoso centrale per indurre la narcolessia.